« I tempi iniziali di tutte le arti sono i più ricchi di poesia, perchè è fatta di primitività e non di esperienza […] Ogni linea, come ogni forma è un miracolo. Mistero dell’arte. Le linee amano lo spazio, creano dei ritmi, logicamente delle funzioni. Sono immense, autorevoli invitano i nostri occhi a disperdersi tra il susseguirsi di linee, forme e colori. »
Atanasio Soldati
Nuoro | Giugno 2023 – Atanasio Soldati, pronuncia queste frasi per descrivere la natura delle sue ricerche espressive, segnate da un’intuito creativo non più legato alla rappresentazione della realtà.
Correva l’anno 1935 e l’Italia viveva un irripetibile fermento creativo di respiro europeista. L’arte mutava significati e forme.
Ho citato quelle parole perché ho colto il linguaggio estetico degli arazzi dello Studio Pratha.
Finalmente sono riuscita a vederli. Sembrava che il tempo avesse ceduto il passo al suo eterno fluire.

Courtesy of Studio Pratha | Museo MAN Nuoro
Lo Studio Pratha è un centro di tessitura a telaio che promuove raffinate sintesi estetiche e mostra di aver assimilato e reinterpretato varie declinazioni e ricerche espressive dell’arte moderna, secondo quella “trasversatilità” (cara a Philippe Daverio) di cui é capace il pensiero umano.
Nasce a Nuoro nel 2017 da un’idea di Graziella Carta, che con capacità imprenditoriale, sensibilità estetica e creativa coinvolge in questo progetto alcune tessitrici del piccolo borgo di Sarule, paese collinare nel cuore della Barbagia.
Donne depositarie di complesse procedure dell’antica tradizione tessile: filano, colorano con prodotti naturali, intrecciano lana di pecora sarda con estrema precisione e accuratezza. Utilizzano l’antico telaio verticale che “suonano” a quattro mani per una resa espressiva più intensa, con giochi di colore: esiti cromatici pulsanti che avvolgono sensi e anima. Un ritmo che definisce il vuoto creativo che per magia apre all’immaginazione e a nuovi pensieri.
Tra gli artisti che hanno realizzato disegni, – legati all’informale, – per i centri di tessitura artigianale, svincolati da patterns tradizionali, ricordo per la sua originalità creativa Mauro Manca (1913-1969) che, – come ricorda Giuliana Altea nell‘opera Tessuti – Tradizione e innovazione della tessitura in Sardegna – “traspone nel tessuto le ricerche che contemporaneamente va conducendo in pittura: nei suoi tappeti troviamo energici tralicci neri su fondo bianco, […] effetti di dripping o di sovrapposizione e “cancellazione” di strati successivi di colore”.

Mauro Manca | Tappeto in lana, Aggius, 1959 | Collezione ISOLA
Accanto a questo progetto avanguardistico (con rimandi all’espressionismo astratto di Jackson Pollock) Manca coltiva la sua idea di tutela della tradizione seppur rinnovandola. E, proprio per le tessitrici di Sarule, realizza alcuni disegni dove accanto alle caratteristiche tessili del luogo (le righe) inserisce elementi innovativi quali la luna e le stelle, accenti simbolici di certa tradizione esoterica.
Oggi, in continuità con l’idea rivoluzionaria di Mauro Manca, che aveva ben compreso come rielaborare la tradizione trasferendovi l’essenza del contemporaneo, l’attenzione agli arazzi dello Studio Pratha – che al momento si possono vedere in una mostra al MAN di Nuoro dal titolo “Pratha – Trame e geometrie”, fino al 25 Giugno, – da parte di operatori e istituzioni museali, nazionali e internazionali, penso sia da ricercare nelle suggestioni e corrispondenze che si sviluppano tra queste opere, la tradizione locale e certe tendenze artistiche d’avanguardia che nell’attuale esposizione sono legate all’astrattismo geometrico della prima metà del secolo scorso.
Infatti, distinguiamo esiti del Bauhaus – scuola tedesca d’arte e mestieri, – dell’astrattismo geometrico sviluppato dal Gruppo Como: Mario Radice, con le sue opere più spirituali, nella sua costante ricerca di proporzioni armoniche legate all’idea del divino o di Manlio Rho, Carla Badiali e tanti altri.
Artisti che in rottura con la tradizione, attribuivano nuovi significati a forme e colori con linguaggi estetici rigorosi, alla ricerca di quella perfezione/verità che inesorabilmente sfugge, legati ad indagini soggettive, più intime e spirituali.
È innegabile la prima emozione: appena si scorgono le opere appese alle pareti del museo, si viene travolti da una vibrante energia: una cascata di puri colori, intensi, accecanti. Come se d’improvviso, camminando sulla battigia, veniamo trascinati via da onde impetuose. Una sensazione incredibile. La stessa che provai quando vidi per la prima volta le tele di Jackson Pollock. Tra colore e gestualità. Rimasi ipnotizzata. E poiché sono opere allover non sapevo più dove guardare. Percepivo solo attrazione per la pluralità di segni e colori. Immaginavo Pollock immerso in una danza tribale che allontanava la sua inquieta malinconia e con le sue bacchette/manici dei pennelli gocciolava vernice sulle tele disposte per terra. Opere immense.
Dopo il primo momento legato al colore, il rimando è stato al laboratorio di tessitura della scuola Bauhaus. Istituzione fondata a Weimar nel 1919 dall’architetto Walter Gropius, anche se ebbe altre sedi in varie città tedesche. prima della sua chiusura nel 1933.
Nata dalla fusione dell’Accademia di Belle Arti con la Scuola di Arti Applicate, vi si svolgeva la didattica per una preparazione tecnica, a cui seguiva una creazione artigianale finalizzata ad una produzione industriale. Contrariamente allo Studio Pratha, dove la creatività si fonde con la progettualità stessa degli arazzi che sono pezzi unici.

New Bauhaus 2022 180×157 cm | Arazzo, Lana di pecora sarda Courtesy of ©️Studio Pratha | Museo MAN Nuoro
L’opera New Bauhaus, 2022 , mostra su una campitura chiara, una resa di trasparenza, una asimmetria armonica in una composizione di figure geometriche realizzate con colori primari, colori simbolo utilizzati da tanti artisti, tra i quali Piet Mondrian nelle sue ricerche neoplastiche a completamento della sua visione geometrico-matematica del mondo di cui cercava di coglierne l’essenza.
Guardando gli elementi di questo arazzo, si può evidenziare una certa staticità. Le figure sembrano sospese. Galleggiano. È presente una certa profondità di campo (assente nelle opere di Mondrian) che si evince nelle ombre riprodotte; e forzando i significati si nota una relazione. Infatti, le cornici teoriche, sono composte da rette (perpendicolari) che s’incontrano, creando angoli retti. Quindi comunicano. Sono unite. Accanto, l’idea di un rettangolo aperto, senza chiusura o barriera che potrebbe alludere a disponibilità, accoglienza. Allusioni etiche. Forse inclusione? Una diversità che va com/presa, pur nella unicità e promuove nuove sintesi?
I due semicerchi (con diametro rivolto al centro) uno situato nella parte inferiore, in prossimità della terra, mentre quello blu, rivolto verso l’alto, un riflesso del cielo, con la presenza di un triangolo sulla sinistra, a cui si può attribuire un valore spirituale, – sembrano delimitare e avvolgere, con le loro semi-circonferenze, le figure centrali, quasi ad aspirare a una conciliazione tra forme geometrico-spaziali, ovvero l’arte, e il contenuto sociale del manufatto quindi il lavoro delle tessitrici, che realizzano trama e ordito, segni dell’agire umano, segni di vita.
Viene superata la ricerca di Mondrian tra arte e vita che nelle sue griglie tentava di raffigurare una conciliazione, un’integrazione.
In New Bauhaus, si può notare un elemento che diversifica: la striscia verticale composta da due rettangoli allungati identici. Posti in continuità. Una perpendicolare, una via di unione alto-basso che sembra procedere oltre l’opera, tra cielo e terra. Forse una chiave di lettura dell’arazzo potrebbe essere che l’arte è essenza della vita, l’una rimanda all’altra. Necessarie per dare senso e contenuti all’esistenza, si alimentano reciprocamente instillate quali parti di una stessa anima, da un essere superiore.
Ecco perché in questi arazzi si percepisce una forte tensione spirituale che rimanda ad un’approccio meditativo, accanto ad una ricerca espressiva e sensibilità estetica per scelte cromatiche e forme geometriche.

Labyrintus 4, 2022 | Arazzo Lana di pecora sarda | Courtesy of Studio Pratha Museo MAN Nuoro
Nell’opera Labyrintus, 2022, si rappresenta un percorso, con elementi disturbanti ripetitivi, problemi, superamenti, ricadute. Rettangoli e quadrati, alcuni strappati, sfilacciati, incompleti. In posizione centrale è raffigurato un quadrato nero a cui tutto sembra tendere in un movimento rotatorio. Un vuoto che crea distacco, ma che ha il potere di illuminare. La profondità è creata dalla disposizione dei rettangoli; allungati, sottili, alcuni con graziosi patterns decorativi, quasi barriere, come pezzi di nastro adesivo, in una struttura armonica. Nulla è casuale, tutto è consequenziale, elementi di sutura per unire parti che altrimenti si perderebbero ma che risultano essere funzionali.
Se forziamo il concetto di sutura tra i rettangoli si potrebbe evocare l’idea di unione, interrelazione quindi collaborazione. Forse l’esperienza lavorativa che vivono le tessitrici, in cui gli arazzi nascono da una coralità di idee, una sinergia che é la forza stessa del gruppo?
Altro riferimento ci viene dato dall’espressionismo astratto. E, tra le varie teorie dei colori qui ricordo quella di Hans Hofmann, esponente di questo movimento americano, che se avesse visto le figure geometriche presenti negli arazzi dello Studio Pratha le avrebbe definite “superfici pulsanti e luminose che emanano una luce mistica”. Quindi esseri viventi. Il cromatismo, quale espediente espressivo, sembra riuscire ad infondere lo spirito vitale.

Dedalo 3, 2022 140×140 | Arazzo lana di pecora sarda | Courtesy of ©️StudioPratha | Museo MAN Nuoro
Guardando l’arazzo Dedalo 3 si può percepire un leggero movimento, secondo la teoria push/pull di Hofmann per la quale alcuni colori “spingono” fuori, emergono, mentre altri sembrano “tirare”, penetrare, allungare lo spazio visivo. Creare distanza.

Particolare Dedalo 3, 2022 ©️Studio Pratha
E precisamente i colori cosiddetti caldi, che si associano alla luminosità del giorno, quindi il giallo, il rosso, l’arancione…spingono verso di noi, nel nostro spazio visivo. Hanno potere attrattivo. Mentre i colori freddi, legati all’oscurità e alla notte il blu, il marrone, il viola, sono distanti, si allontanano dai nostri occhi. Sono più discreti, meno invasivi. Pacati. Distensivi.
E dall’accostamento dei colori si crea movimento proprio perché il colore riflette sfumature diverse. Vibra. Avvolge i sensi. Coinvolge. E permette di respirare quell’aria mistica di cui Hofmann parlava.

Rigore e logica mod. 4d, 2022 180×75 | Arazzo lana di pecora sarda | Courtesy of ©️Studio Pratha ! Museo MAN Nuoro
L’opera Rigore e logica, 2022, mostra un armonioso equilibrio di colori, forme, segni, in cui è ben visibile la tridimensionalità. Se si guarda con atteggiamento contemplativo, liberando la mente dai pensieri, si può percepire.
Abbiamo sezioni di colore e strisce nere e bianche, percorsi che si intersecano, collegano, delimitano. Forse si raffigura la società nella quale si vive? Che ha smarrito queste due categorie: rigore e logica? O riflette l’attuazione dell’opera stessa, tra il rigore della progettazione e la sua realizzazione al telaio, in cui tutto è consequenziale – secondo una linea evolutiva – con la compresenza dell’elemento della tradizione, le righe, che formano il piccolo quadrato?
Avrei desiderato approfondire, poiché non è possibile, spero almeno di aver suscitato in voi la curiosità di visitare il MAN per vedere questi bellissimi arazzi. Posso solo aggiungere che la vera essenza dell’arte é riposta nell’anima di chi crea. Lì, dove confluiscono, in ordine sparso, come fogli di libri gettati al vento. Alla rinfusa. Segni del passato e presente. E tra ricordi, cristalli preziosi della memoria, si r/accorda la contemporaneità. Proprio come gli arazzi realizzati dallo Studio Pratha, in un alone di sincretismo « magico », per quella capacità di sintesi mostrata facendo confluire, con delicato lirismo, tradizione e avanguardia.



















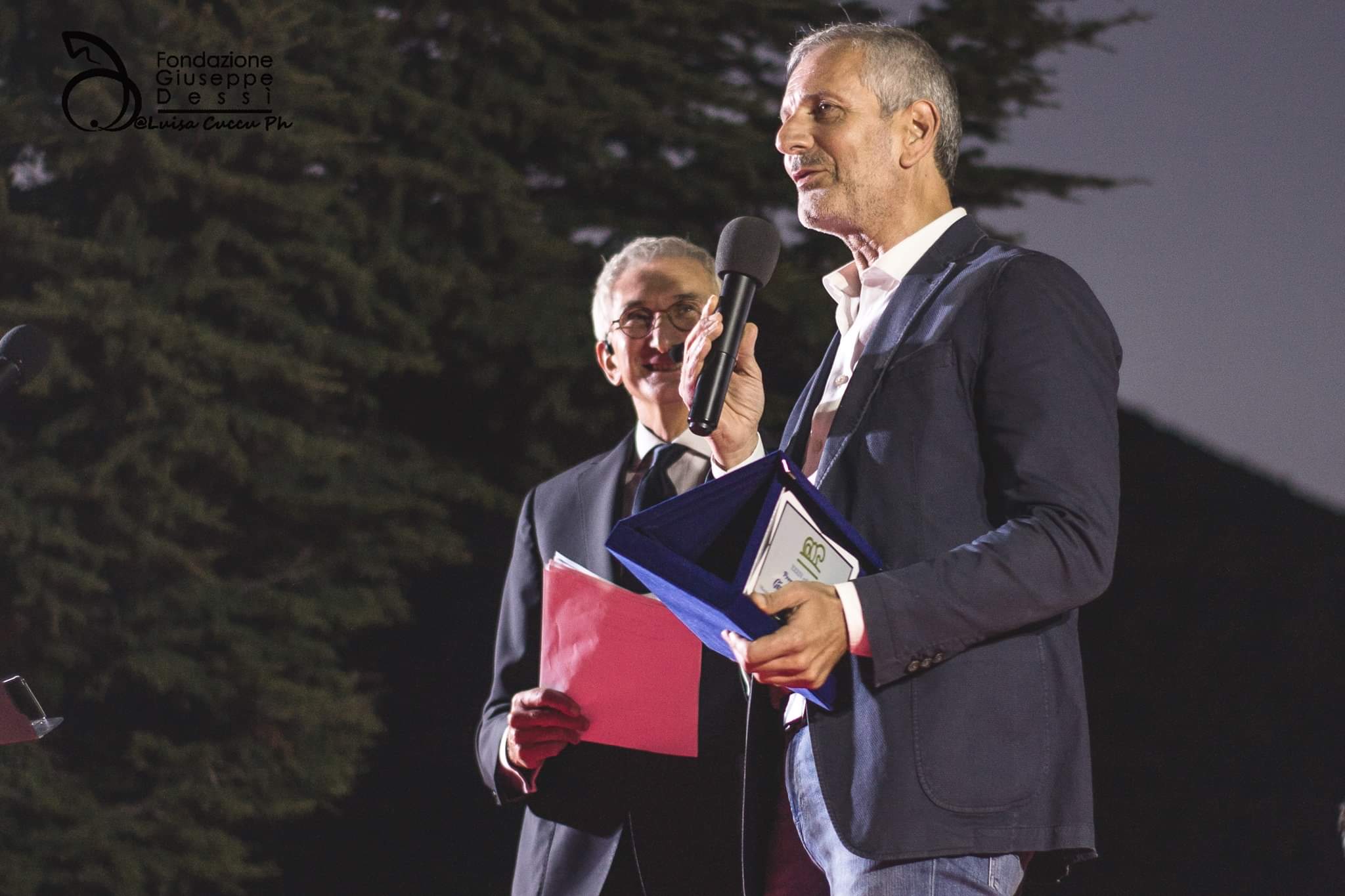






 Re Giorgio, il re del Carnevale Tempiese 2019 – ph. ©LML
Re Giorgio, il re del Carnevale Tempiese 2019 – ph. ©LML  Mannena, moglie di Re Giorgio – ph.©LML
Mannena, moglie di Re Giorgio – ph.©LML Tempio Horror Circus – ph.©LML
Tempio Horror Circus – ph.©LML
 La storia degli anni ’90 – ph.©LML
La storia degli anni ’90 – ph.©LML
 Il manifesto Cyborg (particolare) – ph. ©LML
Il manifesto Cyborg (particolare) – ph. ©LML  È arrivata la mamma di lu soli – Ph. ©LML
È arrivata la mamma di lu soli – Ph. ©LML È arrivata la mamma di lu soli – Ph. ©LML
È arrivata la mamma di lu soli – Ph. ©LML


 The Gospel Voice – ph. ©LML
The Gospel Voice – ph. ©LML

 The Gospel Voice – ph. ©LML
The Gospel Voice – ph. ©LML



